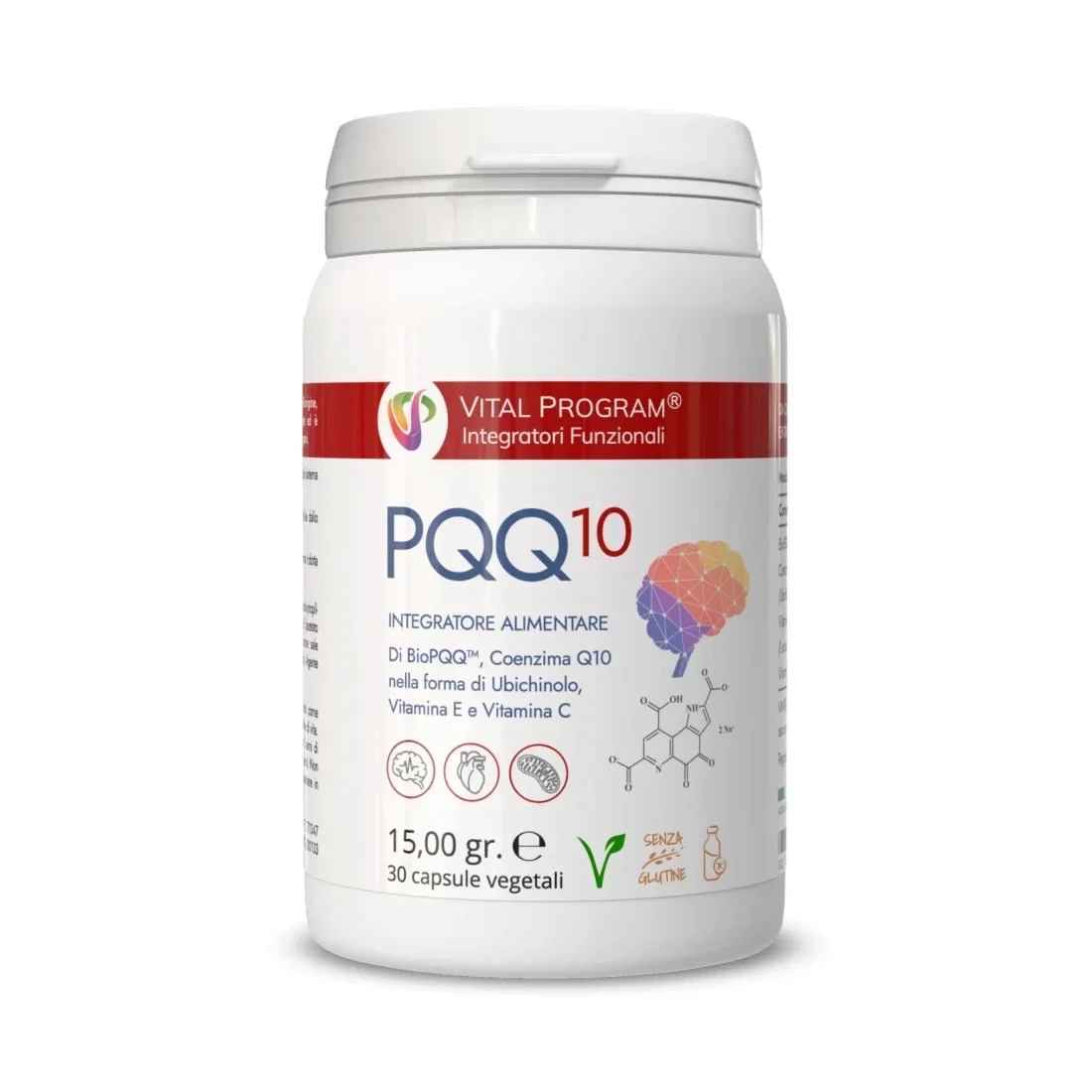
PQQ e Running: il mio test sul “carburante mitocondriale”
Se sei un runner come me, probabilmente hai già provato di tutto: barrette, gel, integratori più o meno miracolosi. Io però mi sono imbattuto in una molecola poco conosciuta ma piuttosto affascinante: il PQQ (pyrroloquinoline quinone).
Non è l’ennesimo stimolante da “botta e via”: si parla di biogenesi mitocondriale. Tradotto: più mitocondri = più centrali energetiche nelle cellule = più efficienza. Almeno in teoria.
Cos’è il PQQ?
Il PQQ è un composto che agisce come cofattore redox, con un’attività antiossidante potente. La ricerca (Nature, 2022) mostra che può stimolare la crescita e la protezione dei mitocondri. In pratica, lavora sulla base biologica dell’energia.
Alcuni studi su esseri umani parlano di benefici cognitivi e cardiovascolari, altri hanno provato a verificarne gli effetti negli sportivi. In particolare, una ricerca su runner non allenati ha testato 20 mg/die di PQQ per 6 settimane… ma il risultato non ha mostrato miglioramenti nelle prestazioni aerobiche rispetto al placebo
Come l’ho usato io
Ho deciso di provarlo in un ciclo personale, senza aspettarmi miracoli:
-
Settimane 1–2 → 10 mg al giorno, al mattino.
-
Settimane 3–8 → 20 mg al giorno.
-
Sempre abbinato al Coenzima Q10, perché i due composti sembrano lavorare bene in sinergia.
Cosa ho sentito sul campo
Non mi ha trasformato in Kipchoge, lo dico subito 😅. Però qualche differenza l’ho percepita:
-
Recupero più rapido: dopo i lunghi non avevo più quella sensazione di “mattone nelle gambe” il giorno successivo.
-
Energia più costante: soprattutto nei lenti, dove mi sentivo meno svuotato.
-
Testa più lucida: utile quando concili corsa, lavoro e vita privata.
L’unico effetto collaterale? Nelle prime due settimane, se lo prendevo troppo tardi, notavo un po’ di insonnia. Ho risolto assumendolo sempre al mattino.
Vale la pena per i runner?
La scienza, per ora, non conferma un boost diretto nelle performance. Però, se consideriamo il recupero, la sensazione di energia più stabile e la resistenza allo stress ossidativo, qualche vantaggio io l’ho visto.
Per chi corre regolarmente e sente che con l’età i tempi di recupero si allungano, potrebbe essere un tassello in più, da usare con criterio.
Come provarlo (se decidi di farlo)
-
Parti da 10 mg/die.
-
Dopo un paio di settimane, se ti trovi bene, sali a 20 mg/die.
-
Un ciclo ragionevole è 8–12 settimane, poi meglio fare pausa.
-
Sempre da associare a allenamento costante, sonno e alimentazione: il PQQ non sostituisce niente di tutto questo.
La mia conclusione
Il PQQ non è la pillola magica del runner. Ma può essere un alleato discreto: ti aiuta a recuperare meglio, a sentirti più “carico” senza stimolanti, e a dare continuità ai tuoi allenamenti.
Io lo tengo come arma in più nei periodi di carico, soprattutto quando preparo i 10 km o le mezze. Non fa correre più veloce, ma ti mette nelle condizioni giuste per allenarti meglio.
E alla fine, è questo che conta.
-

Correre è uno degli sport più naturali e liberatori che ci siano. Basta un paio di scarpe e la voglia di mettersi in movimento per ritrovare energia, benessere e libertà. Ma ogni corsa, lunga o breve che sia, mette alla prova il nostro corpo. I muscoli si affaticano, il sudore aumenta e, insieme ai liquidi, perdiamo anche sali minerali preziosi.
Tra questi, magnesio e potassio sono tra i più importanti: due minerali essenziali che fanno davvero la differenza per chi macina chilometri su strada, in pista o sui sentieri.
A cosa servono davvero?
-
Mantengono i muscoli in forma
Crampi e rigidità sono tra i problemi più comuni di chi corre. Magnesio e potassio aiutano i muscoli a contrarsi e rilassarsi nel modo corretto, riducendo il rischio di fastidi durante l’allenamento. -
Aiutano a combattere la stanchezza
Dopo diversi chilometri, le energie calano. Il magnesio in particolare sostiene il metabolismo energetico, aiutando a mantenere la spinta più a lungo e a recuperare più in fretta. -
Supportano l’idratazione
Quando sudiamo, non perdiamo solo acqua: perdiamo anche elettroliti. Il giusto reintegro aiuta a mantenere l’equilibrio dei liquidi nel corpo, fondamentale per continuare a correre in sicurezza, soprattutto nei mesi caldi.
Quando può servire integrarli
Non tutti hanno bisogno di un integratore ogni giorno. Ma per un runner, ci sono momenti in cui magnesio e potassio diventano utilissimi:
-
Dopo allenamenti intensi o particolarmente lunghi.
-
In estate, quando la sudorazione è più abbondante.
-
Nei periodi di preparazione a gare o allenamenti frequenti, per evitare cali di rendimento.
Un aiuto, non un sostituto
Gli integratori di magnesio e potassio non sostituiscono una buona alimentazione, ma la completano. Frutta, verdura, cereali integrali, frutta secca e legumi ne contengono già in buone quantità. Tuttavia, quando la corsa si fa più impegnativa, un supporto mirato può fare la differenza, mantenendo corpo e mente pronti a dare il massimo.
💬 Nota bene: ogni corpo è diverso. Prima di iniziare a prendere un integratore, meglio sempre chiedere consiglio a un medico o a un nutrizionista, soprattutto se si hanno condizioni particolari o si seguono terapie farmacologiche.
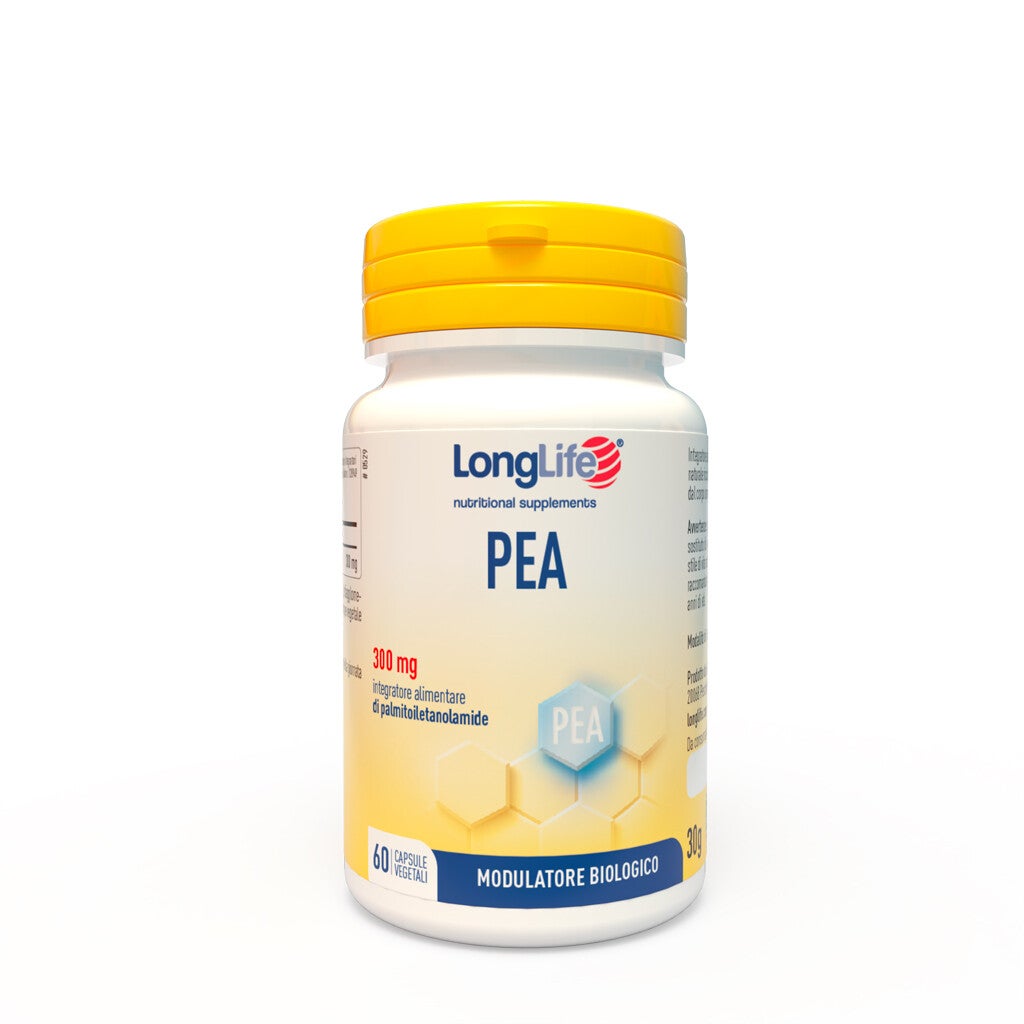
Palmitoiletanolamide (PEA) e running: una revisione critica delle evidenze scientifiche
La palmitoiletanolamide (PEA) è un’amide lipidica endogena appartenente alla famiglia delle N-acil-etanolamine, nota da decenni per le sue proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Il suo meccanismo d’azione si basa principalmente sull’attivazione del recettore nucleare PPAR-α, con modulazione indiretta del sistema endocannabinoide, dei canali TRPV1 e di altri recettori coinvolti nella risposta neuro-infiammatoria. Negli ultimi anni, l’interesse verso questo composto è cresciuto non soltanto in ambito clinico, ma anche nello sport e nella performance fisica, aprendo prospettive di utilizzo nel running come coadiuvante al recupero e all’adattamento muscolare.
Gli studi più rilevanti, condotti finora su giovani adulti sani impegnati in esercizi di resistenza e forza, hanno suggerito un ruolo della PEA nel migliorare i processi di recupero. In particolare, una sperimentazione clinica in doppio cieco ha mostrato come la supplementazione con Levagen+ (una forma biodisponibile di PEA) riduca significativamente i livelli di lattato e mioglobina ematica dopo esercizi intensi con sovraccarico. Questi biomarcatori sono comunemente associati al danno muscolare e all’affaticamento, suggerendo quindi una possibile azione protettiva a livello del tessuto muscolare. Parallelamente, nello stesso contesto è stato osservato un aumento della fosforilazione di protein kinase B (Akt), un pathway molecolare chiave per la sintesi proteica e la rigenerazione muscolare, sebbene non siano stati documentati incrementi diretti di massa muscolare.
Un altro studio di più lunga durata (otto settimane) ha valutato l’effetto di 350 mg/die di PEA su forza, potenza e composizione corporea. I risultati hanno evidenziato un miglioramento significativo della potenza esplosiva, misurata tramite l’altezza del countermovement jump, ma non incrementi nella forza massimale né nella massa muscolare. Questo dato, sebbene limitato, è particolarmente interessante per il running, dove la capacità di esprimere potenza rapida ed elastica può avere un impatto importante, ad esempio negli sprint finali, nei cambi di ritmo o nella corsa in salita.
Sul piano clinico, una serie di metanalisi condotte in ambito non sportivo, ma su pazienti con dolore cronico o neuropatico, conferma la sicurezza della PEA e la sua efficacia nel ridurre l’infiammazione e il dolore percepito. Il profilo di tollerabilità appare favorevole, con assenza di eventi avversi gravi e un margine di sicurezza che ne supporta l’utilizzo anche in protocolli prolungati. Questa caratteristica è rilevante per gli sportivi, in quanto la gestione dell’infiammazione e del dolore post-esercizio rappresenta uno dei principali fattori che condizionano frequenza e intensità degli allenamenti.
Nonostante queste premesse promettenti, occorre sottolineare i limiti della letteratura attuale. Gli studi disponibili sono ancora pochi, con campioni ridotti e condotti in contesti che non prevedono direttamente la corsa come disciplina di riferimento. Manca, ad oggi, un’evidenza specifica sugli effetti della PEA nella performance di endurance: nessuno studio ha valutato parametri come il tempo su distanza, il consumo massimo di ossigeno (VO₂max) o la percezione della fatica in runner di livello amatoriale o agonistico. Inoltre, le differenze osservate tra potenza esplosiva e forza statica suggeriscono che la PEA non agisca in maniera uniforme su tutte le componenti della performance, ma piuttosto su quelle più legate a processi infiammatori e di recupero.
In conclusione, la PEA rappresenta un integratore interessante e sicuro, con evidenze preliminari di efficacia nel ridurre il danno muscolare e favorire il recupero dopo esercizi intensi. Nel running, questi effetti potrebbero tradursi in una maggiore capacità di sostenere carichi di allenamento ravvicinati e in un miglior recupero tra le sessioni, con possibili benefici anche sulla prevenzione degli infortuni. Tuttavia, servono studi clinici mirati su runner per confermare tali ipotesi e chiarire il reale impatto sulla performance di resistenza. Fino ad allora, la PEA può essere considerata un coadiuvante promettente, più orientato al recupero e alla gestione dell’infiammazione che al miglioramento diretto della prestazione cronica.
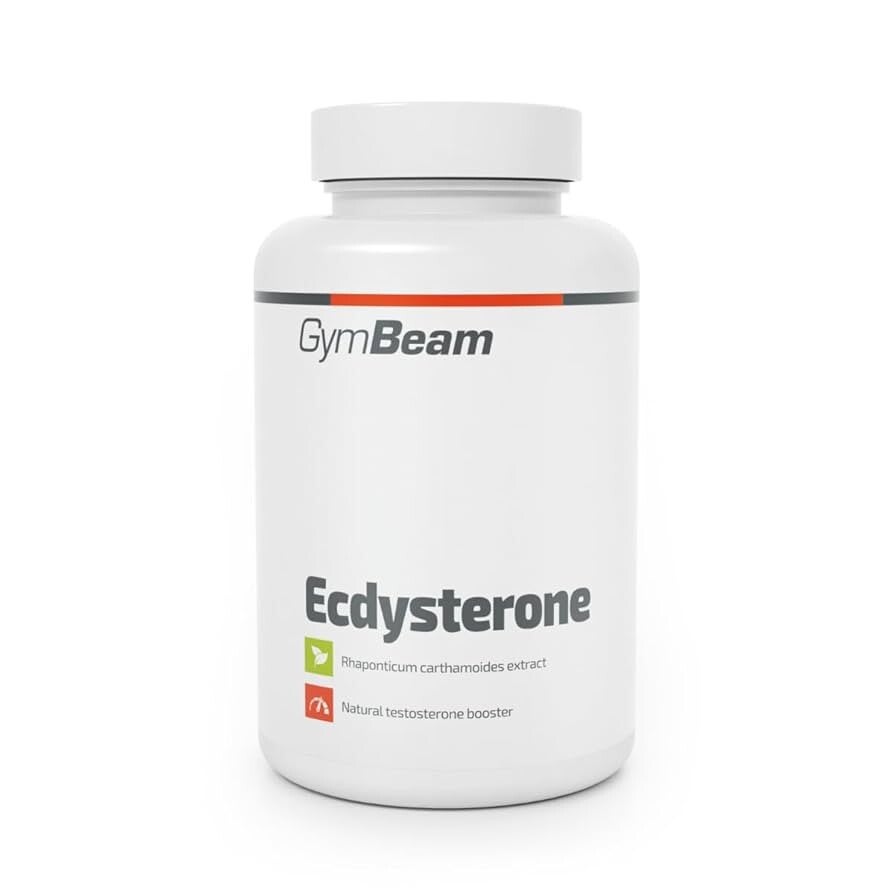
Ecdysterone e running: una revisione critica delle evidenze
L’ecdysterone, conosciuto anche come 20-idrossiecdisone, è un fitoecdisteroide naturalmente presente in diverse piante, tra cui spinaci, Cyanotis vaga e Rhaponticum carthamoides. Originariamente studiato per il suo ruolo negli insetti, negli ultimi anni ha attirato l’attenzione del mondo sportivo grazie al suo potenziale effetto anabolico “naturale”. A differenza degli steroidi anabolizzanti tradizionali, l’ecdysterone non agisce attraverso i recettori androgeni, ma sembra stimolare la crescita muscolare e la sintesi proteica attivando vie metaboliche differenti, in particolare attraverso l’interazione con i recettori estrogenici beta (ERβ) e il pathway PI3K/Akt, cruciale per l’anabolismo muscolare.
Le prime osservazioni in vitro e su modelli animali hanno evidenziato un aumento della sintesi proteica e dell’ipertrofia muscolare paragonabile, in alcuni casi, a quello di steroidi sintetici, ma senza gli effetti collaterali endocrini tipici. Questi risultati hanno stimolato l’interesse della comunità scientifica e portato a studi clinici sugli esseri umani. Uno dei più noti, condotto nel 2019 con il supporto della World Anti-Doping Agency, ha arruolato giovani adulti impegnati in un programma di allenamento di forza per dieci settimane. I risultati hanno mostrato un incremento significativo della massa muscolare e della prestazione al bench press nel gruppo trattato con ecdysterone, senza alterazioni dei marker epatici o renali. Questo studio ha avuto un impatto notevole, tanto da spingere la WADA a considerare l’inclusione dell’ecdysterone nella lista delle sostanze potenzialmente dopanti.
Non tutti gli studi, però, hanno confermato questi risultati. Un trial precedente, condotto nel 2006 su soggetti già allenati, non aveva riscontrato miglioramenti nella composizione corporea o nella performance muscolare. Tali discrepanze potrebbero dipendere dalle differenze nei dosaggi, nella purezza degli estratti utilizzati, nella durata dei protocolli o nel livello di allenamento dei partecipanti. È quindi evidente che, pur essendo promettente, l’evidenza scientifica sull’ecdysterone è ancora limitata e parziale.
Per quanto riguarda il running, non esistono studi specifici che abbiano valutato l’impatto dell’ecdysterone su parametri tipici della resistenza, come VO₂max, tempi di corsa su varie distanze, soglia anaerobica o percezione della fatica. Tuttavia, gli effetti osservati sulla forza e sulla massa muscolare potrebbero avere ricadute indirette anche nella corsa, migliorando l’economia di corsa, la capacità di sostenere allenamenti ad alta intensità e la potenza utile in sprint o salite. Inoltre, la possibilità che l’ecdysterone favorisca il recupero e riduca i tempi di affaticamento muscolare rappresenta un punto di interesse rilevante per i runner che affrontano volumi elevati di allenamento.
In termini di sicurezza, i dati attuali sono rassicuranti: nessuno degli studi clinici ha riportato effetti collaterali seri, né alterazioni a carico del profilo ormonale o degli organi interni. Questa caratteristica, unita al potenziale ergogenico, rende l’ecdysterone un candidato interessante come integratore per atleti, pur con la necessità di ulteriori verifiche.
In conclusione, l’ecdysterone si presenta come una molecola di grande interesse nel panorama della nutrizione sportiva. Gli studi su esseri umani suggeriscono un potenziale effetto anabolico e di miglioramento della performance muscolare, con un profilo di sicurezza favorevole. Tuttavia, mancano evidenze dirette sul running e sull’endurance in generale: servono trial clinici controllati, condotti su runner, per valutare l’effetto su parametri di resistenza, adattamento cardiovascolare e capacità aerobica. Fino ad allora, l’ecdysterone può essere considerato un integratore promettente, ma ancora in fase esplorativa, con applicazioni che nel running restano ipotetiche e tutte da dimostrare.

Glutammina e running: stato dell’arte tra recupero, immunità e performance
La glutammina è l’amminoacido libero più abbondante nel plasma e nel muscolo scheletrico umano. Rappresenta una riserva energetica fondamentale per le cellule del sistema immunitario e dell’epitelio intestinale, oltre a essere coinvolta in numerosi processi metabolici, tra cui la sintesi di nucleotidi, la gluconeogenesi e il mantenimento dell’equilibrio acido-base. Per lungo tempo è stata considerata un integratore chiave per gli sportivi, in particolare nei programmi di endurance, grazie al suo presunto ruolo nel migliorare il recupero, rafforzare le difese immunitarie e ridurre il rischio di infezioni respiratorie dopo allenamenti intensi o gare di lunga durata.
Dal punto di vista fisiologico, durante l’esercizio fisico prolungato le concentrazioni plasmatiche di glutammina tendono a ridursi, in alcuni casi fino al 20–25%. Questa diminuzione è stata associata a un aumento della suscettibilità alle infezioni delle vie respiratorie superiori, condizione frequente nei runner sottoposti a elevati volumi di allenamento o a competizioni impegnative. Proprio su questa base si è sviluppata l’ipotesi che la supplementazione con glutammina potesse prevenire tali episodi, sostenendo la funzione immunitaria. Alcuni studi clinici hanno effettivamente osservato una riduzione dell’incidenza di infezioni nel periodo post-gara con dosaggi di 5–10 g di glutammina somministrati subito dopo l’esercizio.
Tuttavia, la letteratura scientifica successiva ha mostrato risultati contrastanti. Studi più ampi e controllati non hanno sempre confermato un chiaro beneficio della glutammina sulla prevenzione delle infezioni o sul miglioramento della performance. La complessità delle interazioni tra esercizio fisico, immunità e metabolismo degli amminoacidi rende difficile isolare l’effetto specifico della glutammina. Inoltre, le concentrazioni plasmatiche ridotte osservate dopo esercizi intensi non sembrano necessariamente determinare un deficit funzionale delle cellule immunitarie, suggerendo che altri fattori — come lo stress ormonale e la risposta infiammatoria sistemica — possano giocare un ruolo più determinante.
Sul piano della performance, le evidenze sono ancora più deboli. Non esistono prove solide che la supplementazione di glutammina migliori direttamente parametri come il VO₂max, i tempi di corsa o la soglia anaerobica. Alcuni studi hanno suggerito possibili effetti benefici sul recupero muscolare e sulla riduzione del dolore post-esercizio, ma i risultati non sono stati consistenti. Più promettente appare invece il ruolo della glutammina nel supportare la salute intestinale, in particolare nei runner sottoposti a gare lunghe o ultramaratone, dove i disturbi gastrointestinali sono frequenti e possono compromettere la prestazione. In questo contesto, la glutammina sembra contribuire al mantenimento dell’integrità della barriera intestinale, riducendo la permeabilità e l’infiammazione locale.
Un altro ambito di interesse è la combinazione della glutammina con altri substrati energetici. Alcuni lavori hanno evidenziato che la co-somministrazione di glutammina con carboidrati può migliorare il ripristino del glicogeno muscolare dopo esercizi prolungati, potenzialmente facilitando un recupero più rapido tra sessioni ravvicinate di allenamento o gara. Questo effetto sinergico, se confermato, potrebbe avere applicazioni pratiche per i runner che affrontano programmi ad alta frequenza.
In termini di sicurezza, la glutammina è ben tollerata e non sono stati riportati effetti collaterali significativi con dosaggi tipici da 5 a 20 g al giorno, anche in periodi prolungati. Ciò ne rende l’uso sicuro per gli atleti, pur nella consapevolezza che i benefici documentati restano modesti e circoscritti.
In conclusione, la glutammina non può essere considerata un integratore miracoloso per il running. Le evidenze scientifiche indicano che non migliora direttamente la performance aerobica, ma può avere un ruolo nel ridurre il rischio di infezioni respiratorie post-gara, nel proteggere la barriera intestinale durante sforzi prolungati e, in associazione ai carboidrati, nel favorire il recupero del glicogeno. Si tratta quindi di un supporto utile in contesti specifici — gare di lunga durata, ultramaratone, periodi di carichi elevati — piuttosto che di un integratore universale per tutti i runner. Le ricerche future dovranno chiarire meglio i meccanismi e identificare le popolazioni di atleti che possono trarre il massimo beneficio da questo amminoacido così diffuso e studiato.

TMG 500 e corsa: tra scienza e sensazioni
Quando parliamo di integratori per la corsa, la mente va subito a carboidrati, caffeina o creatina. La TMG (trimetilglicina), conosciuta anche come betaina, resta un po’ nell’ombra. Eppure, dietro quelle capsule da 500 mg che molti sportivi prendono distrattamente, si nasconde una molecola che lavora in silenzio, toccando corde profonde del metabolismo.
La TMG è un donatore di metili, e questa sembra quasi un’astrazione chimica finché non la vivi sulla pelle. Significa che partecipa a reazioni invisibili che fanno la differenza tra un corpo che recupera e uno che arranca. Da corridore, la differenza l’ho notata non nei lunghi lenti, ma in quelle giornate in cui la corsa diventa un campo di battaglia: ripetute in salita, lavori a ritmo gara, sprint finali. Lì la TMG sembra regalare un filo in più di elasticità, come se le gambe rispondessero meglio e il cuore si calmassi prima dopo lo sforzo.
La scienza parla chiaro: i dosaggi più studiati sono molto più alti dei 500 mg delle comuni compresse, spesso tra i 2 e i 5 grammi al giorno. Però, anche con dosi più basse, quello che cerco non è il “boost miracoloso” — che nel running raramente esiste — ma una base più solida. Un metabolismo che gira meglio, una barriera in più contro la fatica che si accumula.
C’è poi il lato della salute. Da quando corro tanto, so bene che non è solo questione di gambe: è il cuore, è la circolazione, è la capacità del corpo di gestire lo stress. La TMG riduce i livelli di omocisteina, un parametro che i medici associano al rischio cardiovascolare. Non è un dettaglio, quando chiedi al tuo corpo di reggere chilometri su chilometri, stagione dopo stagione.
Ma non tutto è roseo. La letteratura non è unanime: alcuni studi parlano di miglioramenti nell’economia di corsa e nella potenza, altri non trovano nulla di rilevante. È il classico integratore che divide: chi ci crede e chi lo considera un placebo costoso. Personalmente, l’ho trovato utile come tassello di un puzzle più ampio: non un colpo di bacchetta magica, ma un alleato silenzioso, soprattutto se abbinato a un’alimentazione curata e a un recupero intelligente.
In fondo, il running è una disciplina di dettagli. A volte l’integratore non serve a correre più veloce oggi, ma a permetterti di allenarti meglio domani, con un corpo meno logoro e più pronto. La TMG, in questo senso, entra in quel piccolo spazio tra scienza e sensazione: dove i dati sono ancora in evoluzione, ma l’esperienza personale ti dice che “qualcosa” succede.
Forse è questo il valore di certe sostanze: non ti trasformano in un super-atleta, ma ti danno quella stabilità che serve per continuare a costruire, giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro.
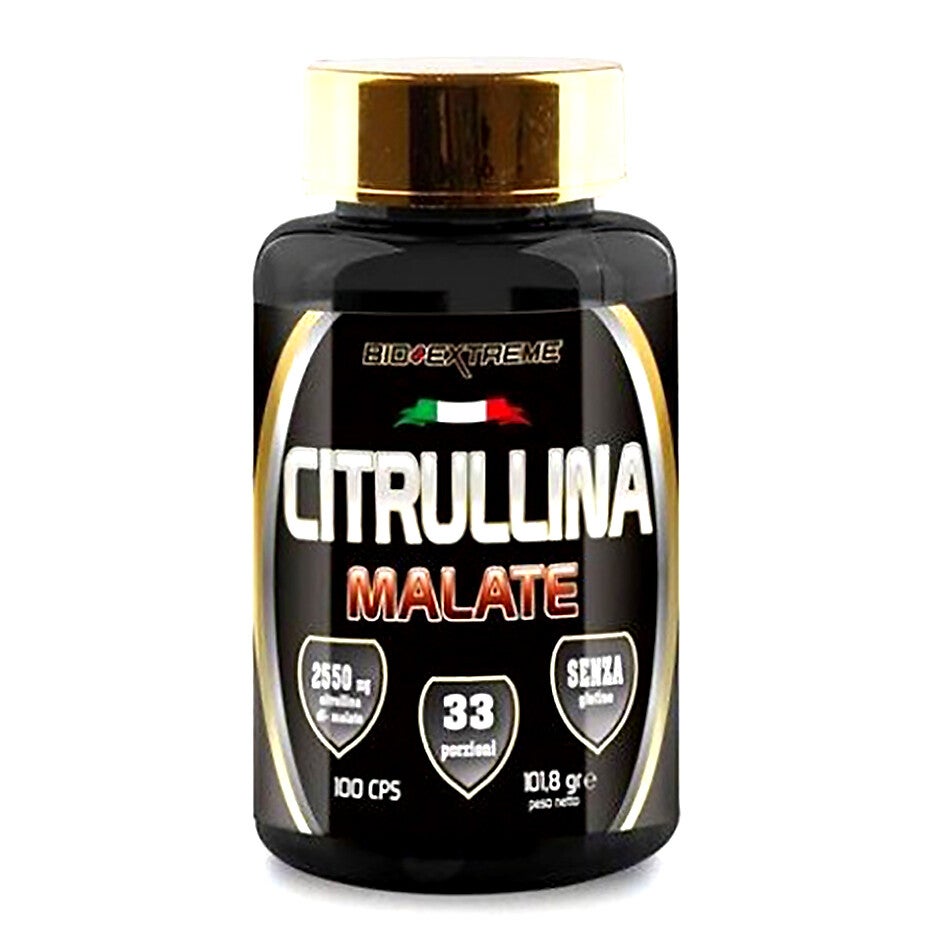
Citrullina malato e corsa: il respiro lungo delle gambe
Tra gli scaffali degli integratori per sportivi la citrullina malato spunta spesso con la promessa di “pompa muscolare” e resistenza. Ma dietro il marketing c’è qualcosa di reale che, da runner, puoi percepire: un filo più di ossigeno nei polmoni e qualche chilometro in più nelle gambe.
La citrullina è un amminoacido non essenziale, trasformato nell’organismo in arginina e quindi in ossido nitrico (NO). E qui sta il punto: più ossido nitrico significa vasodilatazione, quindi vasi sanguigni che si aprono, sangue che scorre meglio, muscoli che ricevono ossigeno e nutrienti con più facilità. Il malato, cioè il sale dell’acido malico a cui è legata, entra invece nel ciclo di Krebs, alimentando il motore energetico delle cellule. Una combinazione che non a caso attira l’attenzione di chi vive di sforzo prolungato, come i runner.
Gli studi parlano di miglioramenti nella resistenza alla fatica e nella capacità di sostenere ripetizioni ad alta intensità. Molti test vengono da discipline di forza, ma ci sono anche dati interessanti sul running e sull’endurance: tempi prolungati al punto di esaurimento, riduzione della sensazione di stanchezza e, in alcuni casi, percezione di un recupero più rapido tra le sessioni. Non parliamo di magie: non è che con la citrullina malato abbassi di cinque minuti il tuo personale sui 10 km. Ma in quelle giornate in cui le gambe sembrano di piombo, la differenza tra mollare e completare il lavoro può essere questione di dettagli.
Personalmente, l’ho provata nelle sedute più dure: ripetute lunghe o salite che ti svuotano. La sensazione non è l’euforia della caffeina, ma qualcosa di più sottile: il fiato sembra più stabile, i muscoli meno “acidi”, il recupero tra un intervallo e l’altro un po’ più veloce. A fine corsa non ti senti “nuovo”, ma neanche distrutto come al solito. È come se la citrullina ti spingesse a galleggiare un po’ di più sopra la fatica.
Le dosi efficaci negli studi sono intorno ai 6–8 grammi, da assumere circa un’ora prima dell’allenamento o della gara. Non tutti tollerano bene queste quantità: in alcuni può dare fastidi gastrointestinali. Ma rispetto ad altri integratori, la citrullina malato ha un profilo di sicurezza piuttosto pulito, senza effetti collaterali seri.
Alla fine, quello che resta è l’idea che la citrullina non sia un “trucco” da bodybuilder, ma un supporto concreto anche per chi macina chilometri. Ti aiuta a respirare meglio con le gambe, non solo con i polmoni. Ti regala quel margine in più per finire le ripetute, per chiudere forte gli ultimi metri, per sopportare meglio la fatica che, nel running, è la compagna inevitabile di ogni progresso.
Non è la chiave che apre tutte le porte, ma è un ingranaggio che, quando gira bene, rende la macchina più fluida. E a volte, nella corsa come nella vita, basta questo: scivolare più leggeri dentro lo sforzo, per poterlo ripetere domani.
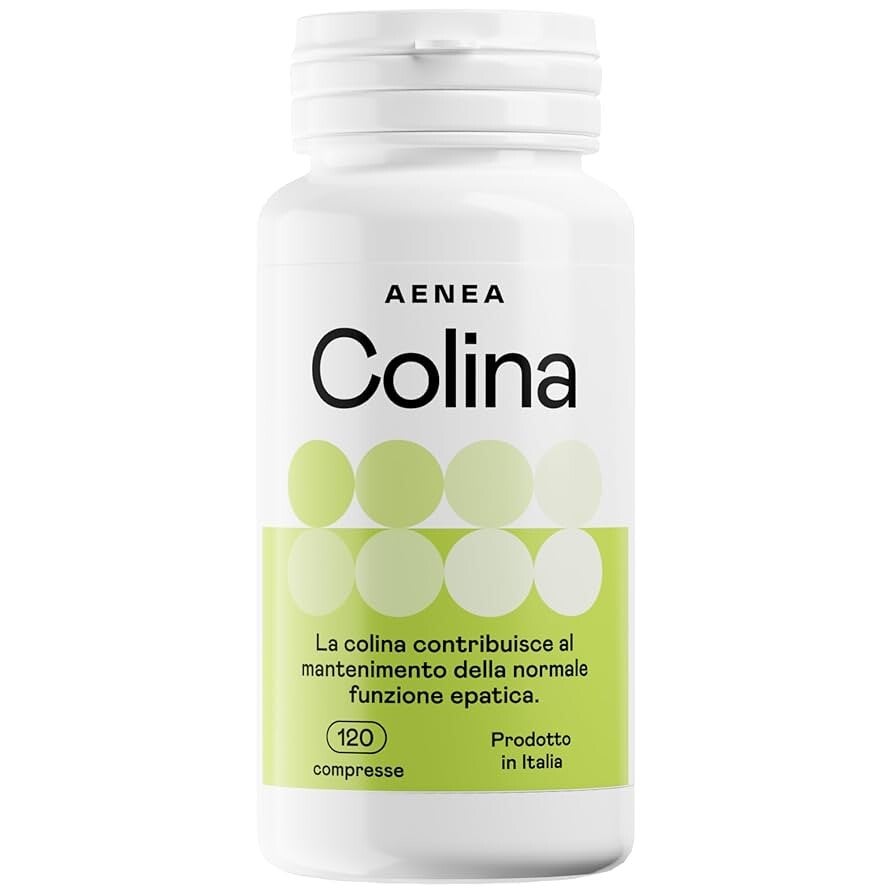
Colina e corsa: carburante per i nervi e resistenza mentale
Quando pensiamo agli integratori per la corsa, immaginiamo subito zuccheri, caffeina, sali minerali. La colina, invece, non è quasi mai nella lista. Eppure è una molecola fondamentale: senza di lei i muscoli risponderebbero peggio, la mente cederebbe prima, e il corpo si incepperebbe in dettagli che a volte fanno la differenza tra un allenamento portato a termine e uno lasciato a metà.
La colina è un nutriente essenziale, parente stretto delle vitamine del gruppo B. Nel corpo è materia prima per due processi chiave: da un lato entra nella sintesi dell’acetilcolina, il neurotrasmettitore che accende la comunicazione tra nervi e muscoli; dall’altro partecipa al metabolismo dei lipidi, permettendo al fegato di gestire i grassi senza accumularli. Per un runner significa due cose: contrazioni muscolari più efficienti e un metabolismo energetico più pulito.
La scienza si è interessata alla colina soprattutto negli sport di lunga durata. In alcune maratone è stato osservato un calo significativo dei livelli plasmatici di colina nei partecipanti, con un legame sospetto con la comparsa di fatica neuromuscolare e calo della concentrazione mentale. Alcuni studi hanno provato a integrare colina prima della gara, riportando risultati contrastanti: in certi casi la supplementazione sembrava ritardare l’esaurimento, in altri non mostrava differenze sostanziali. Probabilmente la variabilità individuale e la dieta di base giocano un ruolo decisivo, dato che la colina si trova anche in alimenti come uova, carne e legumi.
Sul piano personale, la sensazione che ho avuto assumendo colina nei periodi di carico è stata più mentale che fisica. Non un’esplosione di energia come con la caffeina, ma una chiarezza mentale diversa: meno nebbia negli ultimi chilometri, più facilità a restare concentrato sul ritmo, meno errori di passo quando la fatica offusca. Nei lavori lunghi, dove spesso non è il corpo a mollare per primo ma la testa, la colina sembra aiutare a restare “collegati” con quello che stai facendo.
Dal punto di vista della sicurezza, è un integratore ben tollerato ai dosaggi usuali (1–2 g al giorno). A dosi molto alte può dare odore corporeo sgradevole per via della produzione di trimetilammina, ma parliamo di quantità superiori a quelle comunemente usate dagli sportivi.
Alla fine, la colina non è l’integratore che cambia radicalmente la prestazione, ma è un sostegno silenzioso. È come l’accordatura di una chitarra: non si vede, non fa rumore, ma se manca la musica è stonata. Nella corsa, questo si traduce in muscoli che rispondono meglio ai segnali, una mente che resta vigile anche dopo ore, e un recupero metabolico più lineare.
Non tutti i runner ne sentiranno la mancanza, soprattutto se l’alimentazione è già ricca di colina. Ma per chi spinge a lungo, e per chi si accorge che la fatica “colpisce” prima la testa che le gambe, questo piccolo nutriente può diventare un alleato discreto ma prezioso.

Omega 3-6-9 e corsa: equilibrio invisibile che regge la macchina
Quando si parla di integratori per la corsa, i riflettori vanno quasi sempre sugli omega-3. EPA e DHA dei pesci grassi hanno costruito una reputazione solida, fatta di cuore più sano e infiammazione sotto controllo. Ma quando apri una confezione di “omega 3-6-9” ti accorgi che la faccenda è più complessa: dentro c’è un equilibrio di grassi essenziali che lavorano insieme, a volte in sinergia, a volte in conflitto.
Gli omega-3 sono i protagonisti: riducono l’infiammazione, proteggono il sistema cardiovascolare, migliorano la fluidità delle membrane cellulari. Per un runner questo significa recupero più rapido, dolori articolari attenuati e, in alcuni casi, perfino una migliore efficienza cardiaca. Gli omega-6, spesso demonizzati, in realtà servono: partecipano alla risposta infiammatoria (che non è sempre un male, perché l’infiammazione è anche parte della riparazione muscolare). Il problema nasce dall’eccesso, tipico delle diete occidentali, che porta a un’infiammazione cronica di basso grado. Gli omega-9, come l’acido oleico dell’olio d’oliva, non sono essenziali ma completano il quadro con un effetto protettivo su cuore e metabolismo.
Nella pratica, quando ho iniziato a integrare omega 3-6-9, non ho sentito subito un “colpo” di energia. È stato qualcosa di più sottile: meno rigidità al risveglio, più facilità a recuperare tra allenamenti vicini, quella sensazione che i muscoli non restassero infiammati per giorni dopo una gara o delle ripetute dure. Non è l’effetto acuto di una caffeina, ma un fondo di benessere che si costruisce con la costanza.
Gli studi parlano chiaro: l’integrazione con omega-3 riduce i marker infiammatori (come CRP e IL-6), può migliorare la funzione endoteliale e persino la variabilità della frequenza cardiaca, tutti aspetti preziosi per chi corre regolarmente. Alcune ricerche hanno osservato benefici sulla performance aerobica e sulla percezione della fatica, altre meno; la variabilità dipende probabilmente dal livello di base dell’atleta e dalla sua dieta. Gli omega-6 e gli omega-9, invece, giocano un ruolo più indiretto: non sono integratori “da prestazione”, ma componenti di un equilibrio che determina quanto il corpo riesce a gestire lo stress cronico dell’allenamento.
Sul piano della sicurezza, parliamo di sostanze naturali, ben tollerate e sicure alle dosi tipiche. Il punto non è tanto “se fanno male”, quanto “se servono davvero”, perché molto dipende dall’alimentazione di partenza: un runner che mangia spesso pesce, frutta secca e olio extravergine probabilmente non avrà bisogno di integrare. Ma per chi ha una dieta sbilanciata, un supplemento equilibrato di omega 3-6-9 può riequilibrare un terreno infiammatorio e regalare stabilità metabolica.
Alla fine, non considero gli omega 3-6-9 un integratore da gara o da performance immediata. Li vedo più come un investimento sul corpo: meno infiammazione cronica, recuperi più rapidi, un cuore che regge meglio il logorio dei chilometri. È un lavoro invisibile, che non ti fa correre più veloce oggi, ma ti permette di correre meglio e più a lungo domani.

Vitamina D e corsa: la luce dentro i muscoli
La vitamina D è la vitamina del sole. Basta dirlo e ti immagini una giornata limpida, chilometri corsi all’aperto con la luce che scalda la pelle. Ma per molti runner non è così semplice: tra allenamenti mattutini o serali, inverni lunghi e giornate passate in ufficio, il rischio di carenza è reale. E quando manca, non è solo questione di ossa fragili: è tutta la macchina del corpo a girare peggio.
La vitamina D, infatti, non è solo una vitamina, è quasi un ormone regolatore. Controlla il metabolismo del calcio e del fosforo, ma anche la funzione muscolare, immunitaria e perfino quella cardiovascolare. Gli studi mostrano che bassi livelli di vitamina D sono associati a riduzione della forza, maggior rischio di fratture da stress, recupero più lento e un sistema immunitario più vulnerabile. Tutti aspetti che, per un runner, possono fare la differenza tra continuità e stop forzato.
La mia esperienza personale è stata silenziosa: non me ne sono accorto subito. Solo dopo un inverno intero di allenamenti difficili, stanchezza inspiegabile e dolori muscolari strani, un esame del sangue ha rivelato la carenza. L’integrazione non è stata un “colpo di energia”, ma un lento ritorno alla normalità: meno dolori, più brillantezza negli allenamenti, un sistema immunitario che reggeva meglio anche nei periodi di carico. Non era placebo: era il corpo che tornava a funzionare come doveva.
La scienza supporta queste sensazioni. Diversi studi su atleti hanno osservato che la supplementazione con vitamina D (quando c’è una carenza di base) migliora la forza muscolare, riduce il rischio di infortuni e sostiene il sistema immunitario. Non è un “booster” di performance: se hai livelli normali, prenderne di più non ti farà correre più veloce. Ma se sei carente — e molti runner lo sono senza saperlo — può cambiare radicalmente il modo in cui recuperi e ti alleni.
Il dosaggio varia: si parla spesso di 1000–2000 UI al giorno come mantenimento, ma la cosa migliore è sempre misurare i livelli nel sangue e regolare l’integrazione di conseguenza. L’eccesso, infatti, può accumularsi e creare problemi, perché la vitamina D è liposolubile.
In conclusione, la vitamina D è un integratore particolare: non ti dà uno sprint immediato, non ti regala “benzina extra” per la gara di domani. Ti dà piuttosto una base solida, invisibile, che tiene insieme ossa, muscoli e sistema immunitario. È come il sole d’inverno: non lo noti finché non manca, e quando ritorna capisci quanto ti serviva.

Glicerolo monostearato e corsa: la riserva nascosta di acqua ed energia
Il glicerolo monostearato (GMS) non è uno di quegli integratori che trovi spesso nominati nei forum dei runner. Più conosciuto come additivo alimentare, negli ultimi anni ha trovato spazio anche nello sport per un motivo preciso: la sua capacità di aumentare l’idratazione intracellulare, la cosiddetta ipervolemia indotta da glicerolo. In pratica, trattiene più acqua dentro i tessuti, creando una sorta di serbatoio interno che può fare la differenza durante gli sforzi lunghi o in condizioni di caldo estremo.
La scienza ci dice che il glicerolo, assunto insieme a una buona quantità di liquidi, riduce il tasso di disidratazione, abbassa la temperatura corporea durante l’attività e può migliorare la resistenza alla fatica. Il GMS è una delle forme attraverso cui il glicerolo viene veicolato come integratore: legato all’acido stearico, viene metabolizzato e rilascia glicerolo, che poi svolge la sua azione osmotica.
La prima volta che l’ho provato, non ho sentito nulla di spettacolare. Nessuna scarica di energia, nessuna euforia. Ma durante un lungo estivo di 25 km, sotto il sole, mi sono accorto che la sete arrivava più tardi e le gambe tenevano meglio. È un effetto sottile: non corri più veloce, ma ti svuoti meno in fretta. A fine allenamento, invece di sentirmi prosciugato come al solito, avevo ancora una sensazione di “volume”, come se i muscoli fossero rimasti più pieni d’acqua e meno logorati.
Gli studi non sono tantissimi, ma confermano in buona parte queste sensazioni: la supplementazione di glicerolo, in particolare in combinazione con abbondanti liquidi, aumenta il volume plasmatico e riduce lo stress termico. Per i runner questo significa due cose concrete: resistere meglio al caldo e avere un piccolo margine in più quando la disidratazione comincia a pesare. In gare lunghe o trail sotto il sole, ogni dettaglio conta, e qui il dettaglio è qualche grammo di acqua in più trattenuto dentro al corpo.
Sul piano della sicurezza, il GMS è considerato sicuro: è un additivo alimentare comune e, agli usuali dosaggi sportivi, non dà particolari problemi. L’unico effetto collaterale segnalato, se si esagera con le quantità di glicerolo puro, può essere un disturbo gastrointestinale. Con il GMS, soprattutto a dosi moderate, questo rischio è più basso.
Alla fine, non è un integratore da tutti i giorni. Ma quando ti trovi a correre lunghi estivi, maratone calde o gare di trail con poca acqua a disposizione, il GMS può diventare una sorta di “assicurazione nascosta”: non ti rende più veloce, ma ti aiuta a resistere. È come avere una borraccia invisibile dentro i muscoli, che rilascia lentamente ciò che serve quando la sete inizia a mordere.

Curcuma ad alto dosaggio e corsa: spegnere il fuoco dall’interno
La curcuma è una spezia che troviamo facilmente in cucina, ma quando entra nel mondo dello sport non lo fa per insaporire, bensì per la sua molecola più preziosa: la curcumina. Conosciuta per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, negli ultimi anni è stata studiata anche in chi pratica sport di resistenza. E qui il discorso si fa interessante, perché correre significa inevitabilmente produrre infiammazione e micro-danni muscolari.
La curcumina, soprattutto a dosaggi alti (spesso tra 500 mg e 1500 mg al giorno in forma estratta e potenziata con piperina o fosfolipidi), sembra modulare proprio quei processi che, se sfuggono di mano, trasformano l’allenamento in logorio. Gli studi mostrano riduzione dei marker infiammatori (come CRP e IL-6), minor dolore muscolare a insorgenza ritardata (DOMS) e, in alcuni casi, un recupero più rapido tra le sessioni intense.
La prima volta che ho provato la curcuma ad alto dosaggio, non è stata una rivelazione immediata. Nessuna “energia extra” o spinta sulle gambe. L’effetto è arrivato con il tempo: allenamenti lunghi che non lasciavano più quel dolore persistente per giorni, ginocchia che sembravano meno infiammate, una sensazione generale di corpo più “sgrassato” dallo stress. Non un turbo, ma un cuscinetto che assorbe parte dei colpi che la corsa, soprattutto su asfalto, inevitabilmente dà.
La scienza supporta questa impressione. Alcuni studi randomizzati hanno dimostrato che la curcumina riduce i DOMS dopo allenamenti eccentrici, altri che migliora i marker di stress ossidativo in atleti di endurance. Non è un farmaco antinfiammatorio, e non va considerata come sostituto, ma un modulatore delicato, che lavora in sottofondo senza intaccare i processi di adattamento muscolare.
Il lato pratico non è banale: la curcumina ha una biodisponibilità molto bassa se assunta da sola. Per questo le formulazioni “ad alto dosaggio” includono quasi sempre piperina (dal pepe nero) o tecnologie come fitosomi e micelle, che ne aumentano l’assorbimento. Senza queste accortezze, gran parte della molecola passa inosservata nel corpo.
Sul piano della sicurezza, anche a dosaggi elevati, la curcuma è ben tollerata, ma può causare disturbi gastrointestinali in soggetti sensibili. Chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe prestare particolare attenzione, perché la curcumina può potenziare l’effetto fluidificante del sangue.
Alla fine, la curcuma ad alto dosaggio non è un integratore che ti farà correre più veloce in gara. È piuttosto un compagno silenzioso, che ti aiuta a sostenere la costanza degli allenamenti, a ridurre i giorni “persi” per dolori e infiammazioni e a far sì che il corpo regga meglio il carico a lungo termine. È come mettere dell’olio buono negli ingranaggi: non aumenta la potenza del motore, ma gli permette di girare più fluido, più a lungo e con meno attriti.

Ashwagandha KSM-66 e corsa: calma, forza e chilometri
L’ashwagandha è una radice della tradizione ayurvedica, usata da secoli come tonico e adattogeno. Negli ultimi anni è diventata popolare anche nello sport, soprattutto nella sua forma più studiata, il KSM-66, un estratto standardizzato ad alta concentrazione di withanolidi. Dietro al nome esotico c’è un concetto semplice: aiutare il corpo a reggere meglio lo stress, fisico e mentale.
La scienza ci dice che l’ashwagandha KSM-66 abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, migliora la qualità del sonno e supporta la forza muscolare. Alcuni studi hanno osservato aumenti significativi di VO₂max in soggetti che assumevano l’estratto per alcune settimane, segno che può avere un impatto anche sulla resistenza aerobica. Non stiamo parlando di un effetto “doping”, ma di una modulazione dell’equilibrio interno che si traduce in più capacità di recuperare e meno logorio.
La mia esperienza è stata meno “muscolare” e più “mentale”. L’ho percepita nei periodi di carico, quando la corsa non pesa solo alle gambe ma soprattutto alla testa. Con l’ashwagandha ho sentito meno ansia prima degli allenamenti più duri, una concentrazione più calma e una capacità di spingere senza la sensazione di bruciarmi. Non è una caffeina che ti accende, è quasi l’opposto: ti mette a terra, stabile, e da lì puoi costruire chilometri.
Negli studi clinici, la KSM-66 è stata associata a:
-
riduzione della fatica percepita,
-
aumento della forza massimale (soprattutto in esercizi di resistenza),
-
miglioramento della funzione cardiorespiratoria,
-
sostegno alla salute mentale e alla gestione dello stress.
Per un runner questo pacchetto significa più continuità. Allenarsi senza ansia e recuperare con più qualità vuol dire riuscire a sostenere i carichi senza bruciarsi. E questo, nel lungo periodo, è molto più prezioso di un piccolo boost immediato.
Sul piano della sicurezza, la KSM-66 è ben tollerata. Le dosi più comuni negli studi sono tra i 300 e i 600 mg al giorno, spesso suddivisi in due assunzioni. Raramente può causare disturbi gastrointestinali o sonnolenza, ma in generale ha un profilo molto sicuro.
Alla fine, l’ashwagandha non è un integratore “da gara”, è un integratore “da stagione”. Non ti fa correre più veloce domani, ma ti mette nelle condizioni di farlo tra un mese, un anno, cinque anni. È il compagno che ti ricorda che la corsa non è solo gambe forti, ma anche mente calma e corpo in equilibrio.

Amminoacidi ramificati e corsa: tra mito, fatica e recupero
Gli amminoacidi ramificati — leucina, isoleucina e valina — sono forse tra gli integratori più conosciuti dagli sportivi. Hanno attraversato mode e generazioni: dai bodybuilder anni ’80 ai runner moderni che cercano di spingere chilometri su chilometri. Dietro la loro fama c’è una promessa semplice: ridurre la fatica e accelerare il recupero. Ma come sempre, la realtà è un po’ più sfumata.
Dal punto di vista biologico, i BCAA hanno un ruolo centrale nel metabolismo muscolare. La leucina in particolare è un potente segnale anabolico: attiva la via mTOR, che stimola la sintesi proteica e la riparazione dei tessuti. Isoleucina e valina, invece, entrano direttamente come carburante, ossidati nei mitocondri dei muscoli durante esercizi prolungati. Non a caso, nei lavori lunghi di resistenza i livelli plasmatici di BCAA tendono a calare.
La teoria classica sull’endurance è che i BCAA competano con il triptofano per l’ingresso nel cervello. Meno triptofano significa meno serotonina, e quindi meno percezione di fatica centrale. È l’idea che assumere BCAA durante una gara lunga possa “ingannare” il cervello e farti sentire meno stanco. Alcuni studi hanno effettivamente riportato una riduzione della fatica mentale e una maggiore resistenza al cedimento. Altri, però, non hanno trovato differenze sostanziali.
La mia esperienza personale con i BCAA è stata duplice. Quando li prendevo aspettandomi miracoli, restavo deluso: non ho mai visto tempi stravolti o una spinta improvvisa alle gambe. Ma nei periodi di allenamenti pesanti, soprattutto con lunghi ravvicinati o doppie sedute, i BCAA mi davano la sensazione di arrivare al giorno dopo meno “scarico”. Non un turbo, ma un cuscino che attutisce l’impatto della fatica accumulata.
La scienza moderna, in realtà, tende a sottolineare che i BCAA da soli non bastano. La sintesi proteica ottimale richiede tutti gli amminoacidi essenziali, non solo i tre ramificati. Per questo negli ultimi anni hanno guadagnato più attenzione le proteine del siero o gli EAA (Essential Amino Acids) completi, che coprono un profilo più ampio. Tuttavia, i BCAA restano utili in alcune situazioni specifiche:
-
durante gare o allenamenti molto lunghi, per limitare la fatica centrale,
-
in atleti che faticano a raggiungere un adeguato introito proteico,
-
come supporto rapido in fase di recupero.
Sul piano della sicurezza, non ci sono particolari controindicazioni: dosi comuni (5–10 g prima o durante l’attività) sono ben tollerate. L’unico rischio è spenderci troppi soldi aspettandosi benefici che vanno oltre le evidenze reali.
Alla fine, i BCAA non sono l’integratore miracoloso che a volte vengono venduti. Sono piuttosto uno strumento di supporto: aiutano a tenere in piedi il sistema quando lo stress dell’allenamento diventa elevato, ma danno il meglio se inseriti dentro una strategia nutrizionale completa. Non ti fanno correre più veloce oggi, ma possono aiutarti a non crollare domani.
E forse è proprio questo il loro valore nel running: non la magia, ma la costanza. Un piccolo mattone che sostiene la costruzione più grande, fatta di chilometri, recupero e tempo.

Ferro in compresse e corsa: il metallo che porta ossigeno
Per un runner, il ferro non è un semplice minerale: è la chiave che decide quanto ossigeno arriva ai muscoli. È parte dell’emoglobina e della mioglobina, le molecole che trasportano e stoccano l’ossigeno, ed è coinvolto in enzimi fondamentali della produzione energetica mitocondriale. Senza ferro, la corsa diventa un incubo: fiato corto, gambe di piombo, recuperi infiniti.
Gli atleti di endurance, soprattutto le donne, i vegetariani e chi corre volumi elevati, sono spesso a rischio di carenza di ferro. La perdita può avvenire con il sudore, con le micro-emorragie gastrointestinali indotte dall’impatto della corsa, o addirittura attraverso l’“emolisi da piede” (distruzione dei globuli rossi a ogni appoggio). Non è raro che un maratoneta si ritrovi con ferritina bassa e anemia latente senza accorgersene, spiegandosi finalmente i cali di prestazione inspiegabili.
Il ferro in compresse diventa quindi uno strumento diretto: serve a ripristinare le scorte, a riportare ossigeno nei muscoli. La differenza, quando sei carente, è quasi brutale: da correre “soffocando” a sentire di nuovo il respiro fluire. Non è un integratore che ti dà qualcosa in più se sei già a posto, ma se sei in deficit ti restituisce il corpo che avevi perso.
La scienza conferma: la supplementazione orale con ferro (solfato, fumarato, bisglicinato) aumenta i livelli di ferritina e migliora l’emoglobina, con effetti diretti su VO₂max e capacità aerobica negli atleti anemici. Ma negli individui con valori normali non si osservano benefici, anzi: l’eccesso di ferro può accumularsi, diventare tossico e aumentare lo stress ossidativo. È per questo che le linee guida insistono: prima di integrare ferro, serve un esame del sangue.
Dal punto di vista personale, prendere ferro in compresse è stata una cura più che un’integrazione. All’inizio, gli effetti collaterali gastrointestinali (stitichezza, nausea) non sono mancati, soprattutto con il ferro solfato tradizionale. Con formulazioni più delicate, come il ferro bisglicinato, la tolleranza è migliorata. Il vero “effetto” non è arrivato in giorni, ma in settimane: più respiro in salita, gambe meno vuote, allenamenti portati a termine senza la sensazione di trascinarmi.
Alla fine, il ferro non è un integratore “da performance”: è un integratore “da salute”. Serve quando manca, cambia tutto se sei carente, ma è inutile e potenzialmente dannoso se preso a caso. Per i runner è come avere il serbatoio della macchina pieno: senza benzina non ti muovi, ma riempire oltre il tappo non serve a nulla.

Vitamina C e corsa: la barriera contro lo stress
La vitamina C è la vitamina più “pop” che ci sia: la associamo agli agrumi, al sistema immunitario, a quel bicchiere di spremuta che dovrebbe salvare dai raffreddori. Per un runner, però, la vitamina C è qualcosa di più sottile: un alleato invisibile contro lo stress ossidativo e le microlesioni che la corsa porta con sé.
Durante gli allenamenti intensi, soprattutto di lunga durata, i muscoli producono grandi quantità di radicali liberi. Un po’ di stress ossidativo serve: è lo stimolo che innesca gli adattamenti. Troppo stress, invece, significa infiammazione cronica, recupero rallentato, sistema immunitario indebolito. Qui entra in gioco la vitamina C, con la sua funzione di antiossidante e cofattore enzimatico, capace di ridurre i danni cellulari e sostenere la sintesi del collagene, essenziale per tendini, articolazioni e vasi sanguigni.
La scienza ci dice che la vitamina C, soprattutto se assunta regolarmente (200–500 mg al giorno), riduce l’incidenza di infezioni delle vie respiratorie negli atleti sottoposti a stress elevato. Alcuni studi hanno mostrato anche un recupero più rapido dopo esercizi intensi, grazie alla riduzione dei marker di danno muscolare e infiammazione. Ma attenzione: dosaggi molto alti (oltre 1 g al giorno) possono avere l’effetto opposto, “spegnendo” l’adattamento allenante proprio perché eliminano troppo rapidamente lo stress ossidativo che stimola il corpo a migliorare.
Dal lato personale, la vitamina C è stata per me un integratore “di contorno”, non qualcosa che senti subito. Ma nei periodi di carichi pesanti, o in inverno con allenamenti al freddo, ho notato meno raffreddori e meno giornate saltate per malanni. È più una questione di continuità che di performance pura: non ti fa correre più veloce oggi, ma ti aiuta a non fermarti domani.
Sul piano pratico, la vitamina C è sicura, ben tollerata e facilmente accessibile. Gli unici effetti collaterali a dosaggi molto alti possono essere disturbi gastrointestinali. Nei runner, un’integrazione moderata può fare la differenza soprattutto quando la dieta non ne fornisce abbastanza (chi corre tanto e vive di pasti veloci può non coprire i fabbisogni solo con frutta e verdura).
In sintesi, la vitamina C non è un “booster” di performance, ma un protettore silenzioso. Rafforza il sistema immunitario, riduce i tempi di recupero, sostiene le strutture che reggono la corsa. È il tipo di integratore che non senti quando c’è, ma di cui percepisci l’assenza quando manca. Perché la corsa, alla fine, è soprattutto costanza — e la vitamina C è uno degli ingranaggi che ti permette di mantenerla.

Zinco e corsa: il piccolo minerale che tiene insieme il sistema
Lo zinco non ha il fascino degli integratori “alla moda”. Non promette energia immediata, non fa parlare di sé come caffeina o creatina. Eppure, è uno di quei minerali silenziosi senza i quali la macchina non parte: coinvolto in più di 300 reazioni enzimatiche, dalla sintesi proteica alla guarigione dei tessuti, dal metabolismo ormonale al buon funzionamento del sistema immunitario.
Per un runner, lo zinco significa soprattutto due cose: recupero e difese immunitarie. Allenamenti intensi e gare prolungate aumentano lo stress ossidativo e indeboliscono il sistema immunitario; carenze di zinco possono tradursi in più raffreddori, ferite che guariscono lentamente e, a lungo andare, calo della forza e della resistenza.
La scienza conferma: negli atleti con bassi livelli di zinco, la supplementazione migliora parametri immunitari, favorisce la sintesi di testosterone e supporta il metabolismo energetico. Alcuni studi hanno osservato che integrare zinco riduce l’incidenza di infezioni delle vie respiratorie dopo gare di endurance, un aspetto cruciale per chi non vuole fermarsi a metà stagione. Non ci sono prove forti che lo zinco aumenti direttamente la performance di corsa, ma i benefici indiretti — meno malanni, recupero più rapido — possono fare la differenza nel lungo periodo.
Personalmente, ho iniziato a pensare allo zinco nei periodi di maggiore logorio: inverno, carichi intensi, tante gare ravvicinate. Non ho sentito un “boost” immediato, ma meno giornate in cui il corpo sembrava cedere. È come se lo zinco funzionasse da filtro invisibile: riduce il rumore di fondo, toglie di mezzo piccoli intoppi (raffreddori, affaticamenti, recuperi lenti) e lascia che la corsa scorra più lineare.
Sul piano pratico, il dosaggio più comune per gli sportivi varia dai 10 ai 30 mg al giorno. È importante non esagerare: troppi milligrammi di zinco possono ridurre l’assorbimento di rame e ferro, creando squilibri. Alcuni integratori combinano infatti zinco e rame per bilanciare.
In conclusione, lo zinco non è l’integratore che ti fa abbassare il personale sui 10 km. È piuttosto una rete di sicurezza: ti protegge quando il corpo è sotto stress, ti aiuta a recuperare più pulito, ti permette di non fermarti per piccoli acciacchi. In un mondo come quello del running, dove la costanza vale più del colpo di giornata, un minerale così discreto può diventare un alleato prezioso.

Arginina e corsa: aprire le strade al sangue
L’arginina è un amminoacido semi-essenziale: il corpo la produce, ma non sempre in quantità sufficiente, soprattutto quando lo stress fisico aumenta. La sua fama nello sport viene da un compito chiave: è il precursore dell’ossido nitrico (NO), la molecola che dilata i vasi sanguigni e regola il flusso di sangue e ossigeno ai muscoli.
Per un runner, questa promessa è chiara: più ossido nitrico significa gambe meglio irrorate, resistenza più alta, meno fatica. Negli anni l’arginina è stata proposta come “integratore da endurance” proprio per questo motivo.
La scienza, però, racconta una storia sfumata. Alcuni studi hanno mostrato che alte dosi di arginina possono aumentare la disponibilità di ossido nitrico e migliorare la tolleranza allo sforzo. In particolare, in atleti poco allenati o in persone con livelli bassi di NO, si sono visti miglioramenti nell’economia di corsa e nella performance aerobica. Ma in runner già ben allenati, i risultati sono meno evidenti: spesso l’arginina non riesce a innalzare significativamente i livelli di NO perché gran parte viene metabolizzata prima di arrivare al circolo. Per questo oggi molti integratori di nuova generazione preferiscono usare la citrullina, che si converte più efficacemente in arginina nel sangue.
Personalmente, l’arginina l’ho sentita soprattutto nei lavori più lunghi o in salita. Non come una spinta improvvisa, ma come un fiato un po’ più stabile, una sensazione di circolazione più fluida. Negli allenamenti brevi e intensi la differenza era minima; nelle corse di durata, invece, il beneficio era più percepibile, quasi come se le gambe si stancassero un po’ meno in fretta.
Gli studi clinici parlano anche di altri possibili benefici: miglior recupero muscolare grazie a un maggiore afflusso di nutrienti, supporto al sistema immunitario e persino effetti ormonali (alcuni dati collegano l’arginina a un incremento temporaneo della secrezione di GH). Tuttavia, si tratta di effetti più deboli e meno consistenti rispetto ad altri integratori.
Sul piano pratico, le dosi usate vanno dai 3 ai 6 g al giorno, di solito suddivisi in due assunzioni. Ai dosaggi standard l’arginina è ben tollerata, ma può causare disturbi gastrointestinali se presa in quantità elevate o a stomaco vuoto.
In conclusione, l’arginina non è un “miracolo da podio”, ma un integratore che lavora sul contorno: migliora il flusso sanguigno, sostiene la resistenza e può regalare un filo di ossigeno in più, soprattutto nei runner amatoriali o nei periodi di carico pesante. Nei top runner, l’effetto sembra meno netto. È come allargare le strade della città: non fa correre più veloce l’auto, ma rende il traffico più scorrevole.

Beta-Alanina e Running: cosa dice la scienza
La β-alanina (beta-alanina) è un amminoacido non essenziale che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione del mondo sportivo, soprattutto negli sport di resistenza e potenza. La sua funzione principale è quella di aumentare la concentrazione di carnosina all’interno dei muscoli.
Come funziona
La carnosina è un dipeptide che agisce come tampone intracellulare: riduce l’accumulo di ioni idrogeno (H⁺) prodotti durante l’esercizio intenso, ritardando così l’acidosi muscolare, una delle cause principali della sensazione di bruciore e della fatica.
In altre parole, più carnosina significa una maggiore capacità di resistere a sforzi ad alta intensità senza crollare subito.
Applicazioni nella corsa
Per il running, la β-alanina mostra benefici soprattutto nelle prove anaerobiche lattacide e nelle distanze medio-brevi (400 m, 800 m, 1500 m, fino a 10 km in alcuni casi). Qui il corpo lavora ad alta intensità, accumula acido lattico e la capacità tampone diventa determinante.
Per le corse di lunga durata e ritmo costante (mezza maratona, maratona), i benefici diretti sono più limitati, ma potrebbero comunque emergere nei tratti in cui si alternano cambi di ritmo, sprint finali o ripetute in allenamento.
Dosaggi e tempistiche
La β-alanina non funziona come stimolante “istantaneo” da assumere poco prima dell’allenamento. Il suo effetto è cronico: occorre una supplementazione costante per alcune settimane perché le riserve di carnosina muscolare aumentino.
-
Dose efficace: 3,2–6,4 g al giorno, suddivisi in più assunzioni per ridurre l’effetto collaterale più comune, il pizzicore cutaneo (parestesia).
-
Durata: i primi benefici si vedono dopo 4–6 settimane di utilizzo continuativo.
-
Timing: non conta prenderla subito prima di correre; conta l’assunzione regolare nel tempo.
Evidenze scientifiche
-
Meta-analisi (Saunders et al., 2017, Amino Acids): la β-alanina migliora la performance in esercizi che durano da 1 a 4 minuti (zona critica per gare come 800–1500 m).
-
Studi su sport di resistenza: effetti positivi nei ciclisti e nei runner impegnati in prove ad alta intensità intervallata.
-
Limitazioni: benefici modesti o nulli in esercizi di pura lunga durata (>30 min a ritmo costante).
Conclusioni
La β-alanina può essere un alleato interessante per i runner che vogliono:
-
Migliorare la capacità di sostenere ripetute ad alta intensità.
-
Ritardare la fatica muscolare nelle gare di media distanza.
-
Aumentare la resistenza agli sprint finali in gare più lunghe.
Non è una “pillola magica” e non sostituisce un allenamento ben strutturato, ma può offrire un vantaggio concreto a chi pratica running in maniera agonistica, specialmente nelle prove dai 400 ai 10.000 metri.